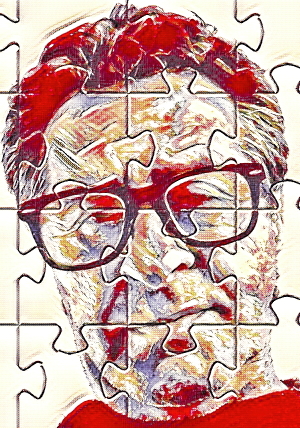Trent’anni fa, forse qualcosa di più, mi capitò per la prima volta di leggere i versi di Luca Florio. Componimenti brevi, a volte didascalici, per lo più a carattere esistenziale e che lasciavano sempre aperto un discorso. Non chiudevano, ma non per incapacità nel farlo, piuttosto come una scelta, una presa di coscienza su di una realtà in divenire, realtà interiore e esteriore, una forma di attesa nella quale “forse (…) scoprirò chi sono”. Si cambia, si evolve, se si vuole, e pure la poesia, il modo di fare poesia muta. I componimenti di Florio divengono più estesi, più strutturati, i versi a volte molto lunghi, ben al di là dell’endecasillabo e al di fuori di quello che può essere il metro tradizionale o consueto della nostra versificazione, si estendono tanto e così improvvisamente che quasi tolgono il fiato, obbligano a fermarti a pensare. Sembrano perdere la musicalità per definirsi in una dimensione quasi saggistica, ma è solo un’impressione, la musica c’è e sta nel suo dispiegarsi e riprendersi all’interno delle pause stesse che il testo impone. Eredità di un certo Pasolini? O forse la memoria, più o meno consapevole, della grande stagione della Beat Generation americana, Ginsberg, Corso, Kaufman, Lucien Carr? Non ha importanza, e pure lui li avrà letti con il senno di poi, quando quella generazione era ormai svanita, forse fallita, ma viva nel mito collettivo degli anni Settanta del secolo scorso, quando Luca era un adolescente. Ma non ha importanza, non sono le eventuali suggestioni che interessano.
Pure in Florio la città, Urbino, è importante, un orizzonte che in un modo o nell’altro si veste come sempre di mito. Ma non è un moto che si rivolge al passato glorioso, a quello che non c’è più, morto e sepolto e che di fronte allo schiamazzare “antico” dei bambini di rione volge uno sguardo indifferente, assente. Ne sono forse dimostrazione su Porta Valbona, come si fossero voltate indietro rimanendo di sale, o come quasi svanite Euridici colte dallo sguardo di un Orfeo che ha deposto la cetra, “le due aquile di pietra [che] tacciono le loro antiche memorie!”. Il ricordo della città è piuttosto quello legato a un’infanzia che non c’è più, consumata, o meglio, goduta, per i vicoli e i luoghi tipici della città, come il Mercatale, dove gli uomini giocavano a bocce sulla ghiaia per un quarto di vino (e in questa bella descrizione del luogo del vecchio mercato del bestiame, Florio non cita la bocca quasi spaventosa della bottega del fabbro posta proprio dove ora c’è l’entrata alla Rampa di Francesco di Giorgio, così viva invece nella mia memoria), e che passava spensierata, la fanciullezza, tra giochi e schiamazzi che Luca sembra rivivere e risentire, evocati forse dalla pioggia che “versa perle / d’ argento su quei teatri del tempo / che fugge inseguendo fragili sogni / dove riposano l’incanto e la giovinezza ormai perdute”, ma che una semplice percezione sensoriale riporta alla realtà contingente, al reale: “C’è un cane che abbaia, / rintocca una campana!”.
E è qui che ritorna il discorso esistenziale, anche se colto da una differente angolazione. Il senso della vita o del tutto, in realtà è un non-senso, esiste e basta, quasi inutile cercarne una motivazione, porsi un orizzonte teleologico. Non si tratta di una rinuncia alla vita e nemmeno di un’assenza di prospettive, quanto piuttosto della presa di coscienza che il vissuto vale essenzialmente per se stessi, che le mutazioni dell’esistenza, pure quelle fisiche, sono necessarie, ma procedono in maniera, si potrebbe dire, casuale e non causale e che ciò che conta alla fine è saper valorizzare “l’importanza che la consapevolezza formula dalle grigie rovine della memoria”, dove tutto sommato ciò che resta e che la libido, nel senso generico del termine come ricerca del piacere, unico vero scopo dell’uomo, sta nel “ritrovarsi in se stessi”, dove “il piacere è dominante”.
Il senso sembra essere, per Florio raccolto quasi in un suono, un suono “che racchiude tutti gli altri suoni”, qualcosa di sensoriale, di reale e percepibile, cioè, la vita stessa che c’è e va vissuta, senza porsi tanto il dilemma di attribuirle un fine, uno scopo, un senso appunto. La realtà si fa viva, regna nella sua dinamica casuale, anche se determinata da tappe, che possono pure essere le età della vita, ma che alla fine rimane l’unico valore veramente dominante, là dove valori assoluti non esistono e non possono esistere in un mondo in cui la mutazione è il carburante stesso che alimenta il motore, e dove nonostante tutto si procede, ci si dirige nella direzione indicata dalle sensazioni che via via si sono fatte immagini, anzi si “rappresentano” in un futuro indeterminato, che non c’è, non ancora. Da ciò, sembra dire Luca, la realtà dell’esistenza prende la propria vita, si rivela come conseguenza questa volta, e, a conti fatti, comunque vadano le cose, ciò che risulta è che “pertanto si può essere in ogni caso!”.
Ciò vale anche per l’arte, per la poesia. “La poesia è ancora praticabile, probabilmente: io me/ la pratico”, scriveva Edoardo Sanguineti nel 1977 e il verso suonava come una domanda. Inutile direi, perché anche la poesia, l’arte, non hanno un senso, non servono a niente, ma ci sono e basta, ci sono sempre state e sono lì pronte o quasi, per chi vuole praticarle, farle o contemplarle, non sono necessarie, sono pur sempre parole scritte sulla neve che svaniranno, è vero, ma assorbite, conservate per sempre dalla terra.
Da al cartone della luce, AAVV, Urbino 1988
Non dire niente
fa che la Vita mi sorrida
e lo stesso mi pianga
fa che mi faccia il suo preferito gioco
e fa che mi distrugga.
Non dire niente
forse qui scoprirò chi sono.
ALTRI VERSI SPARSI
Al cospetto di me stesso.
Chissà’ se potrò’ andare fino in fondo
negli allori delle conseguenze
o se potrò vestirmi di trasparente
mettendo in risalto lo spazio
valorizzando l’ importanza che la consapevolezza formula dalle grigie rovine della memoria;
dato che ritrovandosi in se stessi
il piacere è dominante:
vedo scenicamente in immagini già descritte
il senso di esprimere colorato
e mi dirigo nelle sensazioni che dipendono dalla veste di cui hanno precedentemente rappresentato
da cui ci si dirige tristemente nell’immagine “futurando:”
Con un grido selvaggio
nel grido di un suono che racchiude tutti gli altri suoni, “il senso…”
Io credo che per cui conseguentemente risulti la realtà;
pertanto si può essere in ogni caso!
I teatri del tempo.
C’ era un grande mercatale
fatto di sassi e polvere bianca
dove gli adulti fanciulli con le loro canotte bianche giocavano a bocce:
mettevano in palio, un litro di vino
e una gassosa…
Un ragazzino solitario,
a piedi nudi e le ginocchia sbucciate tira calci ad un barattolo di latta;
tiene strette in una mano, briciole di pane;
nell’altra mano, nasconde il sogno di
un aquilone dal filo strappato
che vola libero lontano!
Bambini scalmanati corrono lungo il torrione, e le due aquile di pietra tacciono le loro antiche memorie!
Da una finestra lontana, una madre grida forte di tornare a casa!
Colori serali indugiano tra i vicoli e nelle strade.
Nella piazza, lo zampillo della fontana è poesia!
Una pioggia leggera versa perle
d’ argento su quei teatri del tempo
che fugge inseguendo fragili sogni
dove riposano l’ incanto e la giovinezza ormai perdute.
C ‘e’ un cane che abbaia,
rintocca una campana!
Nelle notti scritte sulla neve.
“Urbino”
Antiche mura di un’antica città
calpestata dal tempo e dagli uomini
In un gioco crudele per la vita e per
la morte;
tra quelle mura qualche avara
pozza d’ acqua, “ombre malinconiche e tristi che un tempo vuoto ha rapito”:
In quel mondo senza cielo,
tra voci senza corpo,
nel vortice di un malinconico
destino, gridano i sogni nelle notti
scritte sulla neve, dove la luce
dolcemente si pettina e trema un vagabondo sguardo
mentre corre la notte
e vibra come un’ arpa sorda!
Urbino:
città silenziosa ed eterna,
immersa tra il sogno e la veglia;
nell’incanto dei silenzi, d’albe e di
nebbie, tra i confini del tempo e
l’ infinito sguardo tra l’ orizzonte e il cielo.
Urbino;
rifugio antico, oblio secolare
nello scenario senza profondità
di un bianco cielo e nebbia:
beffardo cielo vuoto, della città senza tempo.
Urbino:
il tuo nome e’ puro argento!
Alexanderplaz.
Alexanderplaz, cantava
la meravigliosa Milva dai capelli rossi e la voce limpida…
“In un vecchio cinema sgangherato scorreva un famoso films di
Charlie Chaplin
“e alle luci di quella ribalta, giovani fanciulle danzano nella fantasia dei poeti di Berlino Est!”
Tra grigi oceani di neve e nebbia
s’ odono gli echi di amori infantili;
il riso caro di una madre col suo bambino:
bisbigli di corpi avvinghiati, di amanti pieni di notte nei loro letti assonnati!
Ad Alexanderplaz la luna oscilla col vento, ondeggia come un grande giglio:
bianco fantasma nella grande notte nera dove dormono le stelle.
Un canto, una danza sospesa
dolce come un segreto!
A Berlino est, violando la grande
porta di pietra dell’antica città
che si culla e indugia nell’infanzia,
si consumano delitti!
Alexanderplaz ! “Grida un giovane venditore di giornali col braccio teso verso il cielo!”
Quali mali feroci nei luoghi ritrovati,
luoghi del dolore! “Oltre le lacrime”!
Quanta follia nel frastuono del mondo!
Troneggia nell’azzurro un cuore di neve; la luce muore e il silenzio diventa immenso
ad Alexanderplaz !
*Ninna nanna.
Il venditore di perline d’oro
è un vecchio cieco;
porta con se la sua piaga
nella solitudine selvaggia
di un’eterna notte sorda.
Lo specchio grave dell’età
riflette lunghi solchi severi
tra ombre di rughe trasparenti;
Il vecchio cieco si consuma e piange
e tra le ombre della fantasia,
in quella notte fonda in cui nulla accade, come un fuscello al vento
sprofonda nei silenzi fragorosi della mente, tra la furia della luce!
“Passione,
ferocia,
Oblio”!
Ninna nanna, ninna nanna…
Il mondo perso.
Scrivo ciò che non si può dire
perché la voce a volte
può risultare estranea anche
se è tua:
“scriverò di gioia e di dolore,
della notte e dell’amore!”
Tra gli attimi rubati,
là nella memoria
tra fragori e bisbigli
qualcosa duole nel petto…
“Brrr che brividi !”
E’ questa notte, o la crudeltà
di questo tempo !?
Mondo!
Saggezza o pazzia?
Un uomo.
Io non conto più il tempo
ormai da tanto
ma molto tempo fa e non so quanto,
ho conosciuto un uomo;
era un uomo vissuto della fetida guerra:
lui non parlava, ma il suo corpo
lo diceva;
“lui non voleva!”
La sua voce tremava quando raccontava, si teneva le mani
come dovessero scappare e diceva piano come parlasse da solo:
“Quand’ero ragazzo giocavo alla guerra, ho visto ragazzi giocare alla guerra!”
<<Lo scrosciare della pioggia sulle teste dei soldati, sembrava un rullio di tamburi; la terra tremava e la notte gridava:>> ” armi spezzate sullo sfondo di un tramonto,
un’ombra sospesa…”
Haalt! Chi va la !
Un uomo moriva!.
Le vele del sogno.
Riposa il cuore turbato
con le vele del sogno spiegate
ultimo approdo dei suoi giorni stanchi:
“sia fuori il giorno e la veglia…”
Voci di fanciulli nell’incanto del
tempo, che mai di loro è sazio!
Dio è alle porte!
Dell’ umana follia.
Orizzonti lontani,
fuori da questo mondo terribile,
“dagli inganni consumati
nell’ immenso urlo
dell’ umana follia…”
E di nuovo, di nuovo le rovine hanno
coperto i nudi corpi e urlano
urlano le armi sulle ombre della
città’ fantasma.
Voci bianche annunciano la morte,
la luna si nasconde fra gli specchi
della notte:
Lacrime crudeli nelle sorde tenebre…
Tragica vita, lacrima eterna,
quanta tristezza, quale pena!
Il cuore si spezza:
la cupa e dolorosa coscienza!
Alla rete degli attimi.
Così corse la vita!
Alla rete degli attimi appesa,
bisbigliando parole dimenticate
fra gli specchi della notte che
sorride,
sperduta in un cielo che si nasconde
e che non sa!